Nella letteratura e nella musica, pochi simboli risultano tanto potenti quanto quello della “scimmia sulla spalla”, figura sfuggente, vischiosa, ineluttabile. È un’immagine che non si limita a rappresentare la dipendenza come condizione fisica, ma la trasfigura in stato dell’anima. In Junkie (in italiano La scimmia sulla schiena), William S. Burroughs ne fa il fulcro narrativo del suo memoir brutale e lucido sulla tossicodipendenza. Decenni dopo, in un’Italia molto diversa dall’America marginale degli anni Cinquanta, Eugenio Finardi ne raccoglie l’eco nella sua canzone La scimmia, usandola per raccontare la stessa lotta interiore, con la rabbia poetica di chi ha conosciuto il demone dell’eroina, ma ha anche intravisto una via di riscatto. Due linguaggi, due culture, un unico nodo oscuro: la scimmia sulla spalla.
Burroughs e il suo abisso
Nel 1953 Burroughs, sotto pseudonimo, pubblica La scimmia sulla spalla (Junkie), un resoconto cinico e brutale della dipendenza. Il libro non è né una biografia né un romanzo, ma piuttosto un racconto senza mezzi termini della vita da tossicodipendente nell'America degli anni Cinquanta, scritto con tono distaccato, asciutto, quasi scientifico. La trama segue il protagonista, William Lee (alter ego dello stesso Burroughs), nel suo vagare tra New York, New Orleans e il Messico, alla ricerca di droga e di senso, in un susseguirsi di fughe, arresti, cliniche e rapporti umani alla deriva. In mezzo alle pagine non si trova retorica, e le sostanze, eroina e morfina, sono descritte come compagne di viaggio, talvolta amanti, talvolta carceriere. La scimmia sulla schiena non è solo la dipendenza fisica, ma una condanna esistenziale, una spada di Damocle che pende sulla sua testa. Come scrive Burroughs:
Un tossicomane è un uomo in cerca di una cura, perché l’astinenza è peggio della malattia stessa.
Burroughs annota, osserva e descrive. Il suo modo di scrivere è bruto e non si abbandona al lirismo, ma piuttosto affonda nella verità e nella ripetizione di quei gesti tipici del tossicodipendente. Nel suo scritto si percepisce un’alienazione dal mondo, che lui considera menzognero, falso e così, la metaforica scimmia che porta sulla spalla diventa il suo unico legame autentico, l’unica voce che riconosce in mezzo alle ipocrisie.
Nel libro, Burroughs anticipa già quel che diventerà il suo stile negli anni successivi: lo smembramento del linguaggio, l’esplorazione allucinata della coscienza, il rifiuto delle forme tradizionali. Ma Junkie resta il testo più lineare, quello dove la “scimmia” parla più chiaro: è desiderio, malattia, ma alla fine anche rifugio.
Finardi e il suo canto redentivo
Eugenio Finardi, nel 1978, porta al pubblico una confessione differente. Nella canzone Scimmia, contenuta nell’album Blitz, mette in scena un contesto diverso di dipendenza. Non ne parla in modo distaccato e cinico come Burroughs, ma con il fuoco interiore di chi c’è dentro e, in quei quattro minuti e cinquantatré secondi, racconta l’odissea della dipendenza da eroina.
La genesi del brano è profondamente autobiografica: Finardi, pur non essendo mai diventato un tossicodipendente, ha vissuto da vicino l’ambiente della droga negli anni Settanta, vedendo amici cadere nel baratro e sentendone il peso addosso. Scimmia nasce così come uno sfogo urgente, un grido contro un mondo che attrae e distrugge allo stesso tempo, e come un atto di consapevolezza politica e personale.
La scimmia di Finardi ti segue, ti viene a cercare, non ti molla. Ma nelle note della canzone si avverte un tentativo di riflessione, di riscatto, e anche la musica dietro sembra intrappolata nella spirale della dipendenza. Fin dall’inizio, “il primo buco lo feci una sera a casa di un amico, così per provare”, si avverte un misto di desolazione e rassegnazione, ma poi le sue parole si fanno più aggressive e, di nota in nota, arriva la voglia di redimersi, di finirla con quella vita. La scimmia non è solo una dipendenza, ma una sfida per Finardi e, cantandola, esprime questa voglia di “giocarci contro”, di liberazione.
La scimmia come archetipo
Nel confronto tra i due autori, il simbolo della “scimmia” assume un significato archetipico. Non si tratta solo di droga: è la personificazione del vuoto, dell’assenza di senso, della necessità di evasione. Per Burroughs, la “scimmia” è un riflesso della sua alienazione borghese e del rifiuto del modello americano. Per Finardi, è una risposta tragica e violenta alla noia, al conformismo, al dolore generazionale, come si intende dalle prime note della canzone. Entrambi, pur partendo da vissuti e poetiche diverse, convergono su una stessa verità: la dipendenza non è una colpa, ma una condizione dell’essere. Non esiste un giudizio morale, è qualcosa che ti prende e che ti svuota. E qui il parallelismo tra i due autori si fa profondo; entrambi, con le parole, cercano un modo per affrontare il demone della dipendenza, questa scimmia che, posata sulle loro spalle, li estranea e non permette loro di vivere una vita, ma piuttosto di affrontare una non-vita, giornate fatte di maniere per “svoltare” i soldi per la dose, come poi verrà anche affrontato in molti lungometraggi, a partire da Trainspotting, Amore tossico e Requiem for a Dream.
Lo stile come specchio
Anche nello stile i due si parlano, anzi, forse per meglio dire si specchiano. Dove Burroughs tace e rappresenta inerzia, Finardi urla e grida di dolore. Dove il primo è cinico e asettico, il secondo è appassionato, partecipe. Burroughs nasconde il sentimento, mentre Finardi, usando la voce come una lama, lo espone. Ma entrambi arrivano alla stessa conclusione: che questa scimmia è un paradigma della non-esistenza e, al contempo, della voglia di esistere.
La redenzione
In entrambe le opere c’è un sentimento di redenzione: mentre Burroughs la cerca con il linguaggio, con un’opera successiva, Pasto nudo, che segnerà una rottura totale con la linearità, una liberazione mentale, Finardi la insegue con l’impegno, con la musica, con un redimersi più concreto; la sua scimmia non scompare, ma viene guardata negli occhi.
Ecco forse la differenza più netta tra i due: Burroughs si rifà a un’estetica di disfacimento, mentre Finardi affronta il suo demone, andando avanti. I periodi storici e i contesti sono diversi, ma entrambi sanno che la “scimmia” non scompare all’improvviso, ma rimane lì, annidata in qualche angolo oscuro della mente, sempre pronta a tornare.
Il dialogo tra Junkie e La scimmia è un duetto che attraversa gli anni, gli oceani, le forme espressive. È la prova che la dipendenza non è solo una condizione fisica o sociale, ma una dimensione profonda dell’esistenza. Burroughs e Finardi, in due modi diversi, ci obbligano a guardare quella parte di noi che cerca la fuga nell’oblio, nel tunnel, che rifiuta la realtà e teme la libertà, rinchiudendosi in un labirinto mentale, come Teseo col Minotauro.
Entrambi, con le loro “scimmie”, ci offrono uno specchio. E forse il vero atto di coraggio non è smettere con la droga in sé, ma continuare a cantare, a scrivere. Perché nominare questo demone è già un modo per renderlo meno potente.
Federico Valenti

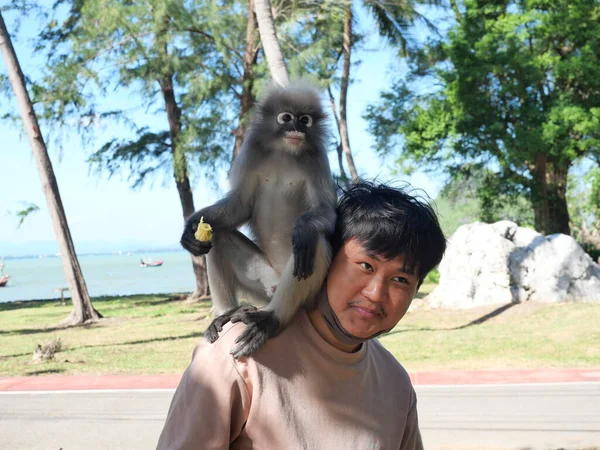


Nessun commento:
Posta un commento