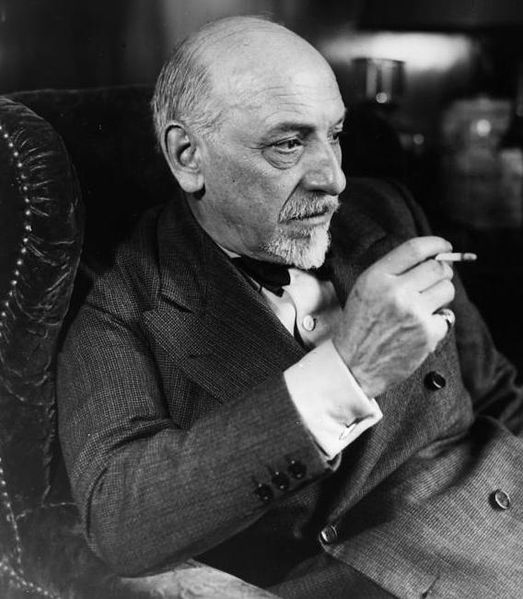|
| © Ph. Wilfried Krüger | Pina Bausch |
Il mondo dell’arte ormai da tempo ci ha abituati a delle manifestazioni molto interessanti, ibride, che si potrebbero definire “osmotiche”, in cui le sue varie forme sono caratterizzate da un passaggio di elementi che ne cambiano i connotati originari. Così il teatro si mescola con il cinema, la pittura con la fotografia, la musica con la letteratura. E il pubblico assiste mostrando reazioni completamente diverse, a volte una promettente curiosità, altre completa perplessità, ma, nella maggior parte dei casi, questi esperimenti artistici non passano inosservati e non restano in ombra, ma diventano, anzi, oggetto di studi e approfondimenti. Uno degli esempi meglio riusciti e più importanti di “osmosi artistiche” nella storia della cultura recente è quello del Tanztheater della danzatrice e coreografa Pina Bausch.





.jpeg/725px-Ruzzante_(Tomasini).jpeg)