"Dio è morto, Marx è morto e anche io non mi sento tanto bene."
Nell’inverno del 1997 Woody Allen è morto. Almeno per me.
Dopo aver terminato Harry a pezzi nient’altro che il prolifico regista americano puntualmente ogni anno, ci propina, sembra essere all’altezza della stagione d’oro che ha vissuto tra la fine degli anni settanta (da Io e Annie) e quella fatidica data. Quella della sua morte, appunto. Ma siccome la morte, notoriamente, «nobilita l’uomo» e ancor di più l’artista, ecco i critici europei non mancare mai al puntuale appuntamento – a Cannes o a Venezia – con lo sperticato elogio del maestro.
«Segnali d’imperfetta morte», per dirla con le parole d’un grande scrittore, s’erano visti da tempo, per la verità, ma dopo quell’ultima testamentaria opera che racchiude tutte le ossessioni cinematografiche di Allen – autobiografismo, comicità brillante e surreale, analisi psicologica, folgoranti ‘trovate’ a servizio d’una tecnica a volte inefficace – il nostro sembra vagolare, sperduto, nella notte della senilità.
So già che state pensando a Match Point (2005), che lo stesso Allen ha definito il suo miglior film, ma si stratta di un (auto)plagio, certo non privo di geniali intuizioni, o a Vicky Cristina Barcelona (2008) che non aggiunge niente alla sua carriera, ma che s’è beccato la denuncia dello scrittore Alexis de Vilar che lo ritiene un plagio del suo Goodbye, Barcelona.
In realtà certe caratteristiche i suoi film le hanno sempre avute – e parlo anche del plagio – solo che l’icastica che allora – quando era in vita – trasbordava potente dai suoi film, rendeva queste caratteristiche dei “marchi di fabbrica”. Eccone alcuni:







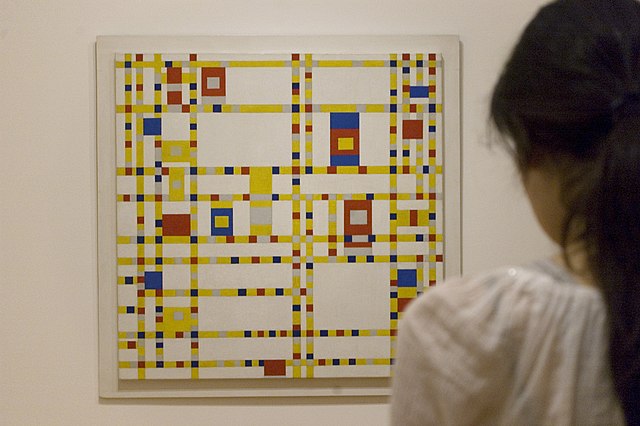


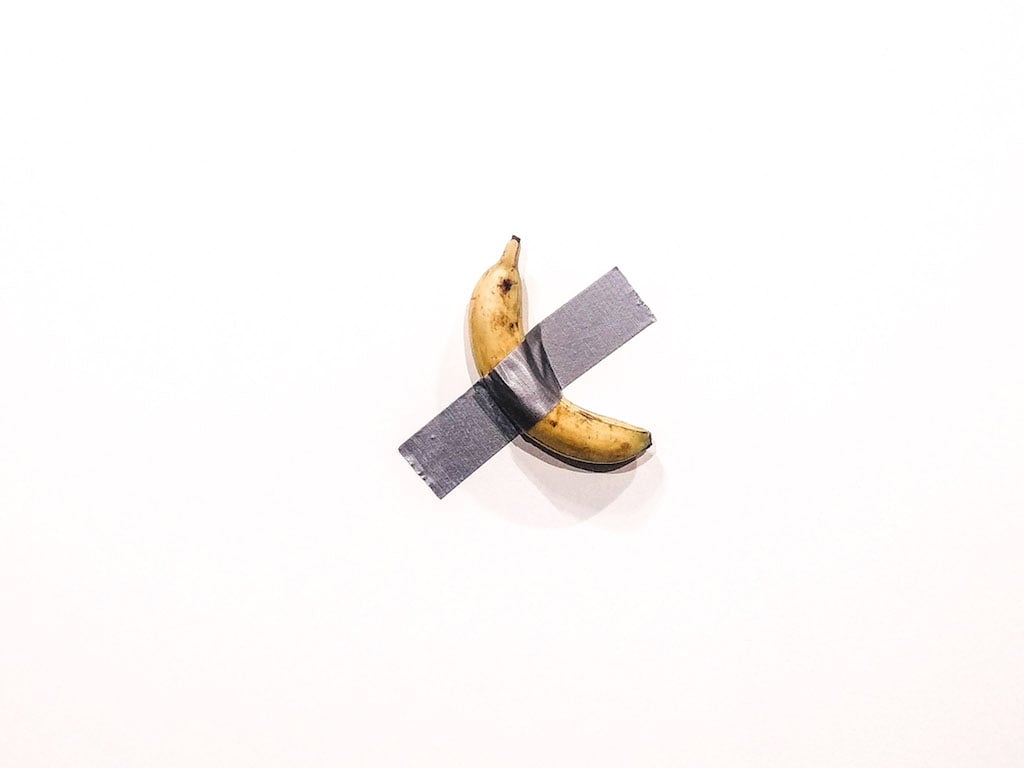








.jpeg/220px-Woody_Allen_(2006).jpeg)


